L’organizzazione interna
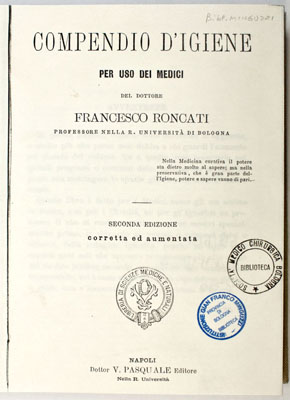 Come Roncati pensava che dovesse essere costruito e organizzato un asilo per alienati è scritto nel suo Compendio d’igiene (1887): qui, dopo aver elencato le norme igieniche da seguire per la costruzione degli ospedali generali, Roncati affronta la questione particolare di quelli destinati al ricovero e alla cura dei pazzi.
Come Roncati pensava che dovesse essere costruito e organizzato un asilo per alienati è scritto nel suo Compendio d’igiene (1887): qui, dopo aver elencato le norme igieniche da seguire per la costruzione degli ospedali generali, Roncati affronta la questione particolare di quelli destinati al ricovero e alla cura dei pazzi.
Se nell’aspetto esteriore un manicomio dovrebbe rassomigliare il più possibile a un ospedale comune – a padiglioni o corpi staccati – o meglio ancora “ad un’abitazione ordinaria”, l’organizzazione interna, invece, dovrebbe tener conto delle classi sociali dei ricoverati nella predisposizione dello spazio manicomiale e delle attività da svolgere durante il giorno: idea, questa, comune presso gli alienisti dell’epoca (1). Locazione delle camere, occupazione lavorativa o ricreativa, cambiavano a seconda che l’internato fosse povero o ricco: allocato in basso e occupato in lavori manuali o nei campi, il primo; allocato in alto e occupato in letture e altri svaghi, il secondo, in quanto persona “non usata al lavoro”. Pur tenendo conto delle loro esigenze speciali, Roncati è convinto che anche i “ricchi immattiti” debbano essere curati in manicomio: sia perché non guarirebbero restando nelle proprie case, sia perché farebbero correre il rischio d’impazzimento ai propri cari, tanto più che, come non evita di rilevare e parla “d’esperienza”, il medico stesso corre quel pericolo stando a contatto con il paziente.
L’abbellimento della costruzione nel caso delle persone colte, civili, agiate, viene motivato sulla base dell’eventuale disgusto morale, e perciò del danno psichico che deriverebbe dall’ “obbligata convivenza con pazzi della classe povera, proletaria od agricola”.
Sempre richiamandosi a una concezione tipica della psichiatria del periodo, l’ergoterapia (o terapia del lavoro) era parte fondamentale della cura morale dei pazzi. “Per lo più inaccessibili alla logica del discorso, quando li si volesse convincere della falsità delle loro idee” – scriveva Roncati – i matti sono invece “ben acconci a quell’ordine di idee ed atti, che si richiede per un lavoro”. Tra l’altro, la presenza all’interno del manicomio di luoghi adatti per officine di calzolaio, fabbro, falegname, e lavorazione di stoffe, offriva, oltre al vantaggio terapeutico dell’ergoterapia, quello economico di ottenere servizi a basso costo.
Circa le suddivisioni da porre in essere nel manicomio, Roncati anzitutto individua quella tra uomini e donne (data come auto evidente), ma auspica anche, per le grandi città, la costruzione di due diversi manicomi: uno più piccolo, “dentro le mura, o lor prossimo, dove ricoverare i malati di forme acute o tenere in osservazione i nuovi venuti con malattia non appariscente”, e un altro più grande, “in aperta campagna, per le forme di corso lungo o croniche, e nominatamente per malati campagnoli, e per tutti quelli che soffrono di stato anemico, ecc.”. Va ricordato che Roncati si era battuto personalmente per ottenere l’allocazione del nuovo stabilimento dentro le mura di Bologna. Quando Rizzoli gli aveva domandato il suo parere, Roncati aveva risposto in una lettera (2) che, proprio perché sede di studi universitari, Bologna avrebbe certamente avuto bisogno di un luogo “di mera osservazione” delle malattie mentali e, collocando il manicomio dentro le mura, si sarebbe potuta facilmente destinare una sezione di questo a luogo di osservazione, laddove, se fosse stato allocato fuori, ne sarebbe occorso un altro a tal fine.
Lo spazio manicomiale in quanto ospedaliero – dove dunque, secondo Roncati, non dovrebbero essere “accettate quelle forme di idiotismo, cretinismo, imbecillità e demenza cronica, che non sono di pericolo né vogliono cure” – dovrebbe essere suddiviso in cinque sezioni. Nel già citato Compendio d’igiene Roncati indicava anche una sorta di distribuzione ideale dei ricoverati:
- dei tranquilli e puliti, compresi i convalescenti, nella proporzione del 44%;
- dei semiagitati o meglio semitranquilli, nel rapporto del 36%;
- dei sucidi e distruttori non agitati, che sogliono essere l’8%;
- degli affetti di malattie fisiche comuni, 2%;
- dei deliranti agitati, rumorosi, pericolosi, da computare al 10% (per le donne al 12).
La sezione dei deliranti agitati dovrebbe conciliare la terapia dell’isolamento, utile a costoro, con la garanzia della massima sicurezza per tutti gli altri ricoverati. Ai semiagitati dovrebbero essere destinate camere singole o con pochi letti, e assegnati luoghi di passeggio e riunione. La sezione dei sucidi (leggasi sudici) sarà allocata in un compartimento a corpo staccato, dove sia garantita la massima ventilazione. Tutti (tranne i furiosi e gli affetti da malattie comuni) mangeranno insieme, e godranno di luoghi di passeggio al chiuso (appositamente riscaldati) e all’aperto, di spazi per la ginnastica e l’intrattenimento (bocce, teatro, scuola, sale di lettura e visite). E inoltre, anche per il socialista Roncati, “una chiesuola servirà a modeste funzioni religiose, esclusone tutto quanto possa eccitare soverchio l’immaginativa, o condurre a scrupoli e temenze spaventose”.
Il vestiario, se fornito dal manicomio ai pazzi poveri anche per scopi igienici, non dovrà necessariamente essere reso uniforme per tutti i ricoverati: perché “il vestiario e l’acconciatura personale hanno grande influenza sullo stato psichico di molte persone”. Con acume psicologico Roncati precisa che “non dovrebbe tollerarsi un vestire troppo dimesso e pezzente in chi delira di abbiettezza o miserabilità, né un abbigliamento di croci, ciondoli e nastri negli ammalati con orgoglio, ambizione e vanità fastosa”.
Quanto all’utilizzo di mezzi coercitivi, la visione di Roncati non può certo essere definita libertaria: se nel Compendio ribadisce fermamente l’innegabile utilità che questi hanno nella gestione dei corpi degli internati durante i loro momenti di escandescenza – soprattutto per evitare che dagli scontri fisici con gli infermieri possano venir loro fratture traumatiche, a volte anche letali –, nello scritto successivo Ragioni e modi di costruzione ed ordinamento del manicomio provinciale di Bologna (1891) ne esalta l’utilizzo anche “a fini di correzione ed intendimento disciplinare”, asserendo subito dopo: “Perché mai abolire i mezzi coercitivi in un manicomio, mentre esso medesimo ha natura coercitiva, o di forzata reclusione (sì che un mio malato lo chiamava argutamente «il coercicomio»)?”. Ciò non toglie, o anzi esige perché sia terapeutica, che l’applicazione dei mezzi coercitivi “dev’essere sempre umana nei modi, breve al possibile, e motivata”.
Prima della legge n. 36 Disposizioni sui manicomi e sugli alienati del 1904 che lo sancirà, Roncati sostiene la necessità di affidare pieni poteri al direttore: questi deve essere medico ben esperto e avere ampia ingerenza anche nelle faccende amministrative, al fine di predisporre al meglio quanto concorra al risanamento e alla cura dei malati.
Un ultimo appunto Roncati lo dedica a tratteggiare il “buon infermiere”. Figura centrale nella organizzazione della cura manicomiale, l’infermiere è la persona che di fatto ha più contatto e familiarità con il ricoverato. Roncati scrive che gli infermieri rappresentano “i principali strumenti” di quelle cure morali, di cui il medico “assegna poco più che l’indirizzo” (tant’è che se la media proporzione di numero auspicata tra infermieri e alienati è di 1 a 10, quella tra medico e internati è di 1 a 100), ma è specchio fedele della situazione in cui versavano i manicomi, non solo italiani. Resta il problema della loro formazione: “Un infermiere – aggiunge Roncati – dovrebbe avere un lungo tirocinio, od anzi qualche indirizzo dottrinale (…) ed in lui dovrebbero andar di pari l’intelligenza e la solerzia con la pacatezza del carattere e l’educazione dei modi”
Nelle pagine del suo Compendio Roncati non dice se quanto andava affermando fosse stato realizzato o fosse in corso di attuazione nel manicomio di Bologna da lui diretto. Ci restano alcune descrizioni del manicomio bolognese che ci presentano un ospedale ben organizzato e funzionante, ma, non prive di sfumature agiografiche, soprattutto nei confronti del direttore, lasciano qualche incertezza sulla loro veridicità.
NOTE
1. Si veda il saggio di Fernanda Minuz, "Gli psichiatri italiani e l’immagine della loro scienza (1860-1875)" in V. P. Babini, M. Cotti, F. Minuz, A. Tagliavini, Tra sapere e potere. La psichiatria italiana nella seconda metà dell’Ottocento, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 27-75.
2. Lettera di Roncati a Rizzoli del 29 marzo 1867, riportata in Eugenio Dall’Osso, “La costituzione in Bologna dell’Ospedale Psichiatrico «Roncati»”, in Bullettino delle scienze mediche, Bologna, anno 1956, pp. 228-9.
Elisa Montanari