La fisiologia sociale applicata all’infanzia. Il ruolo di Pietro Albertoni
 “Signori! Io non voglio ulteriormente dilungarmi in questo studio di fisiologia sociale e ne lascio ai giovani lo sviluppo. […] Spero che la nostra gioventù universitaria penserà a questa soluzione scientifica della questione sociale e sarò ben lieto di averne fatto nascere il desiderio. Chiedete che la mercede equivalga almeno alle perdite fisiologiche fatte nel lavoro; chiedete una legislazione che consacri il diritto all’alimento ed al lavoro, senza orpelli.Ma sia questo, od altro migliore, abbiate un ideale e combattete fortemente per esso. Guardatevi dall’apatia che snerva corpo ed anima. La censura vi corregga, ma non vi sgomenti; perché guai a colui che il vento della censura non viene a scuotere mai”.
“Signori! Io non voglio ulteriormente dilungarmi in questo studio di fisiologia sociale e ne lascio ai giovani lo sviluppo. […] Spero che la nostra gioventù universitaria penserà a questa soluzione scientifica della questione sociale e sarò ben lieto di averne fatto nascere il desiderio. Chiedete che la mercede equivalga almeno alle perdite fisiologiche fatte nel lavoro; chiedete una legislazione che consacri il diritto all’alimento ed al lavoro, senza orpelli.Ma sia questo, od altro migliore, abbiate un ideale e combattete fortemente per esso. Guardatevi dall’apatia che snerva corpo ed anima. La censura vi corregga, ma non vi sgomenti; perché guai a colui che il vento della censura non viene a scuotere mai”.
Con queste parole Pietro Albertoni concludeva la prolusione di apertura dell’anno accademico 1890-1891 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna. Da sei anni professore alla cattedra di Fisiologia e direttore del relativo gabinetto scientifico, Albertoni esprimeva in questo “manifesto programmatico” del suo pensiero scientifico l’indirizzo futuro delle sue ricerche. Ripubblicato più volte in Italia e tempestivamente tradotto da Charles Richet nella Revue Scientifique (1891), il celebre discorso inaugurale assegnerà ad Albertoni la fama di fondatore in Italia della fisiologia sociale, branca della più vasta “medicina sociale”, termine con cui andava qualificandosi la produzione medica italiana degli ultimi anni dell’Ottocento e che era la chiara espressione del desiderio degli scienziati di intervenire attivamente nella formazione del giovane stato, fornendo “una base scientifica e positiva” a una “riorganizzazione razionale della società”. E, soprattutto, era l’espressione della volontà di mettere la scienza al servizio della risoluzione della “questione sociale” che, esplosa in tutta la sua drammaticità all’alba dell’unità, spingeva lo sguardo scientifico verso le condizioni di vita delle classi subalterne.
Del positivismo medico italiano Albertoni condivideva l’idea di una scienza che fosse insieme utile e applicata e concepiva la fisiologia nel suo ruolo essenziale di “scienza sociale” al servizio della collettività: “in faccia a questa questione sociale che ha per termini pane e lavoro, la Fisiologia non può rimanere muta di consigli e di indirizzi, dal momento che essa, come studia i fenomeni dell’organismo umano e le leggi da cui sono governati, così stabilisce le leggi dell’alimentazione e del lavoro dell’uomo” – sosteneva il professore sempre nella prolusione.
È proprio a partire dalla cattedra di Bologna e dalle indagini svolte nel laboratorio a essa annesso che gli interessi scientifici di Albertoni, prima rivolti specialmente a ricerche fisiologiche e farmacologiche sulla corteccia cerebrale e sulla genesi dell’epilessia (prima a Siena e poi a Genova mentre è direttore di un reparto ospedaliero per malati mentali), si indirizzano verso la fisiologia dell’alimentazione e del lavoro, acquistando quello specifico respiro sociale che caratterizzerà le sue ricerche successive. Ne sono un esempio le prime indagini sperimentali, compiute con l’allievo Ivo Novi, sul bilancio nutritivo del contadino italiano (1892 - 1924) a partire dal confronto tra una famiglia contadina emiliana e una borghese della stessa zona, e poi estese a famiglie di contadini abruzzesi, ferraresi e veneti. Per evitare che le ricerche fossero svolte su un “uomo artificiale” il professore proponeva un nuovo metodo di “ricerca sul campo” che osservasse l’oggetto scientifico “lasciando le famiglie alle loro condizioni abituali, circostanza di importanza essenziale” (1) poiché permetteva di prendere in considerazione le variabili delle condizioni di vita e dell’ambiente: “se si vogliono risultati veramente attendibili non il soggetto deve venire al laboratorio, ma il laboratorio deve portarsi in casa del soggetto dell’esperimento”.(2)
Dalle osservazioni risultava che la deficienza di principi alimentari azotati e delle albumine nell’alimentazione delle classi più povere era la causa di quella “miseria fisiologica” (già individuata grazie ai precedenti studi sulla pellagra, considerata da Albertoni “malattia da carenza alimentare” in opposizione alla più accettata tesi “tossicozeista” di Lombroso) che era veicolo, insieme all’eccesso di lavoro e alle pessime condizioni igieniche, di degenerazioni fisiche e mentali e dell’alta e precoce mortalità. Rispetto alla quantità del cibo introdotto peso ancora maggiore spettava alla sua qualità: erano quindi le condizioni economiche e sociali a determinare il “pervertimento” delle condizioni fisiologiche. Dai risultati delle indagini era chiaramente visibile la stretta connessione che intercorreva tra nutrizione, lavoro, attività cerebrale, funzioni biologiche e condizioni socio-economiche: le “verità fisiologiche” erano cartine tornasole di disuguaglianze sociali, ma contemporaneamente base direttiva di intervento per nuove riforme.
“Gli interessi della Società non devono essere in opposizione coi bisogni fisiologici dell’organismo; altrimenti gli uomini, quando non siano eroi o martiri, sono spinti alla ribellione e al delitto”, affermava Albertoni nella celebre prolusione. Per promuovere il progresso di tutta la nazione era necessario promuovere il benessere pubblico attraverso quel “minimo di giustizia sociale misurata scientificamente attraverso la valutazione dei bisogni fisiologici”: un “sano e retto socialismo” diveniva, per Albertoni, verità scientifica. Inevitabile era il risvolto in questioni politiche, per il professore in “difetto di positivismo”, e il suo intervento attivo nella vita cittadina e nazionale.
Lo stretto legame tra impegno scientifico, sociale e politico e il chiaro incontro tra mentalità positivistica e gli ideali del movimento socialista (che nasceva in quegli anni con l’istituzione del Partito dei Lavoratori Italiani - 1892) era, come si diceva, fenomeno nazionale e la città di Bologna, negli anni in cui la sua cultura scientifica stava conoscendo uno dei suoi momenti più alti, non era da meno vantando la presenza di numerosi docenti universitari negli organi elettivi locali e in Parlamento.(3)
Tra le file dei radicali nelle elezioni nazionali (Deputato in Parlamento per tre legislature nel collegio di Bozzolo dal 1892 al 1904 e nel 1912 Senatore per volere di Giolitti), Albertoni lottava per il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti proponendo importanti riforme in senso democratico e popolare (ne è un esempio il radicale progetto di legge di riforma tributaria, proposto nel 1893 insieme a Prampolini, Badaloni e Bovio) e interveniva più volte nelle questioni di pubblica istruzione. Ma è soprattutto nell’ambito dell’attività amministrativa comunale (1889-1916) che le sue proposte politiche furono rivolte in modo più mirato all’infanzia, terreno scientifico poco conosciuto ma che proprio in quegli anni stava attirando l’attenzione del panorama medico, fisiologico, antropologico e psichiatrico italiano (cfr. Ugo Pizzoli e la nascita della pedagogia scientifica in Italia e Cronologia essenziale) ed era l’oggetto delle principali discussioni politiche e sanitarie, mosse dall’urgenza di far fronte all’altissima mortalità infantile e dalla profonda convinzione teorica che solo a partire dal benessere e dall’educazione delle nuove generazioni potesse attuarsi la “rigenerazione” del nuovo stato.
Luigi Bombicci, professore di Mineralogia all’Università di  Bologna, “invece di parlare di minerali o di cristalli” decideva di dedicare la prolusione di apertura dell’anno accademico 1891-92 – Dall’Asilo infantile all’Ateneo attraverso le questioni sociali – a questioni pedagogiche: gli ambiti scientifici bolognesi più diversi convergevano in quella direzione, l’Università vantava in quegli anni la presenza di nomi celebri della pedagogia come quello di Pietro Siciliani e, anche se per breve tempo, di Giuseppe Sergi, ed era la seconda in Italia a fondare una clinica pediatrica (in un’ala del Sant’Orsola nel 1899).
Bologna, “invece di parlare di minerali o di cristalli” decideva di dedicare la prolusione di apertura dell’anno accademico 1891-92 – Dall’Asilo infantile all’Ateneo attraverso le questioni sociali – a questioni pedagogiche: gli ambiti scientifici bolognesi più diversi convergevano in quella direzione, l’Università vantava in quegli anni la presenza di nomi celebri della pedagogia come quello di Pietro Siciliani e, anche se per breve tempo, di Giuseppe Sergi, ed era la seconda in Italia a fondare una clinica pediatrica (in un’ala del Sant’Orsola nel 1899).
In questa atmosfera, fu centrale il ruolo scientifico del professore Albertoni: si formarono, infatti, nella sua “scuola” quei personaggi chiave che fecero di Bologna un centro nevralgico in Italia per lo sviluppo di una scienza dell’infanzia. Si laureavano con lui Ugo Pizzoli e Giulio Cesare Ferrari, rispettivamente nel 1888 e nel 1892, e avevano seguito i suoi corsi di “fisiologia igienica e applicata” Alfredo Boselli e Giuseppe Bellei, figure importanti dell’igiene pedagogica, e Umberto Loreta, il quale avrebbe in seguito dedicato le sue ricerche alla pedagogia del bambino dopo aver combattuto per l’istituzione di sezioni infantili negli ospedali. Furono per lo più gli allievi e i collaboratori di Albertoni i professori chiamati da Pizzoli a intervenire al primo corso italiano di pedagogia scientifica, inauguratosi nell’agosto del 1902 a Crevalcore, piccolo paesino della provincia bolognese, (cfr. Ugo Pizzoli e la nascita della pedagogia scientifica in Italia), gli stessi che contribuirono poi ai primi numeri della Rivista di Psicologia applicata alla Pedagogia e alla Psicopatologia, la prima rivista italiana dedicata interamente alla psicologia, nata nel 1905 per iniziativa di Ferrari.
Fedele all’idea, sulla linea di Pasquale Villari, del positivismo come metodo che poneva le radici della scienza nella pratica sperimentale, non appena arrivato a Bologna, Albertoni intercedeva più volte sul Rettore per l’acquisto di “strumenti indispensabili” affinché il Gabinetto di Fisiologia fosse ben fornito ed efficiente. Ed evidentemente il buon risultato raggiunto lo spingeva a rifiutare nel 1890 il trasferimento alla cattedra di Fisiologia dell’Università di Firenze: “non ho mai anteposto il mio vantaggio personale, che in questo caso sarebbe significante, a quello scientifico. Vostra Eccellenza sa che a Bologna il mio laboratorio ha Lire 3000 di dotazione, due assistenti, un inserviente. Naturalmente non mi muoverei se a Firenze trovassi condizioni peggiori” – scriveva il professore al Rettore dell’Ateneo fiorentino. (4)
 Il laboratorio di Albertoni era uno dei meglio forniti in Italia ed era a disposizione di tutti coloro che in quegli anni stavano dedicando l’attenzione all’infanzia. Non solo punto di riferimento scientifico quindi, l’Istituto di Fisiologia fu punto di appoggio tecnico per le indagini sperimentali di fisiologia igienica e di igiene pedagogica svolte dai medici bolognesi soprattutto nel campo delle malattie della scuola e del rendimento scolastico. Di più. Attraverso il veicolo di queste indagini la fisiologia sociale di Albertoni avrebbe preluso alla nascita della psicologia sperimentale in Italia: proprio nel suo laboratorio Ferrari avrebbe tenuto, infatti, le lezioni dimostrative del corso libero di psicologia sperimentale per gli studenti di medicina affidatogli per l’anno accademico 1904-1905, mentre era direttore dell’Istituto medico-pedagogico emiliano per piccoli disabili mentali. (5) (cfr. Giulio Cesare Ferrari e il personale dell’Istituto medico-pedagogico emiliano).
Il laboratorio di Albertoni era uno dei meglio forniti in Italia ed era a disposizione di tutti coloro che in quegli anni stavano dedicando l’attenzione all’infanzia. Non solo punto di riferimento scientifico quindi, l’Istituto di Fisiologia fu punto di appoggio tecnico per le indagini sperimentali di fisiologia igienica e di igiene pedagogica svolte dai medici bolognesi soprattutto nel campo delle malattie della scuola e del rendimento scolastico. Di più. Attraverso il veicolo di queste indagini la fisiologia sociale di Albertoni avrebbe preluso alla nascita della psicologia sperimentale in Italia: proprio nel suo laboratorio Ferrari avrebbe tenuto, infatti, le lezioni dimostrative del corso libero di psicologia sperimentale per gli studenti di medicina affidatogli per l’anno accademico 1904-1905, mentre era direttore dell’Istituto medico-pedagogico emiliano per piccoli disabili mentali. (5) (cfr. Giulio Cesare Ferrari e il personale dell’Istituto medico-pedagogico emiliano).
Prima di quegli anni nel laboratorio di Albertoni si svolgevano le indagini sperimentali sul rapporto tra la posizione assunta dai bambini nel banco scolastico e la funzione del respiro e tra lavoro scolastico e acutezza visiva, per ricordare le più importanti, del medico provinciale Giuseppe Badaloni, i cui risultati furono pubblicati in quel testo - Le malattie della scuola e la loro profilassi (1901) - che rese Badaloni uno degli esponenti più rappresentativi dell’igiene pedagogica, poi ripresi e approfonditi sulle pagine del Bullettino delle scienze mediche, di cui Albertoni era Direttore (6). E quando ancora non era stato istituito un “laboratorio d’igiene scolastica” (1908) si appoggiavano a quello del “caro maestro” Boselli e Bellei per le indagini sanitarie che svolsero nelle aule scolastiche di Bologna, mentre erano a capo del servizio sanitario scolastico dell’Ufficio d’Igiene (1898). Cfr. La medicina nelle scuole: Bologna all’avanguardia nell’igiene pedagogica. I due medici si rendevano presto conto che, oltre alle indagini prettamente igieniche di cui erano stati incaricati, erano necessarie indagini più squisitamente fisiologiche e psicologiche:
“Riconoscemmo ancora che, oltre alle malattie diffusive, era necessario occuparsi di altre forme morbose, le quali possono avere una ripercussione sulla volontà, sull’attenzione, sullo sviluppo dell’intelligenza degli scolari, e che di conseguenza possono condurre il maestro su false vie, a giudizi errati, a punizioni ingiuste […] non è certamente facendo scrivere cento volte la frase ‘io sono un fanciullo disattento’ che potrà essere vinta la disattenzione di un fanciullo debole e anemico”. O ancora: “Il compito dei medici nelle scuole non deve essere esclusivamente limitato alla osservazione delle malattie diffusive e contagiose; ma deve esplicarsi nello studio delle qualità psichiche e morali, dello sviluppo dell’intelligenza, delle condizioni che ostacolano o difficultano il lavoro cerebrale, delle cause che diminuiscono o favoriscono l’attenzione, uno dei coefficienti più forti del sapere”. (7)
Da queste considerazioni presero il via gli importanti studi di Boselli sul rapporto tra sviluppo fisico, sesso, età, condizioni economiche e familiari e rendimento scolastico (8) e quelli di Bellei sulla fatica mentale scolastica dovuta al sovraccarico intellettuale, una delle maggiori cause del fenomeno sempre più diffuso nelle aule scolastiche di un precoce esaurimento nervoso (9). Le ricerche di Bellei furono 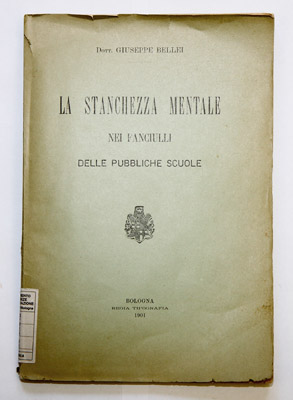 pubblicate nel 1901 nel testo La stanchezza mentale nei fanciulli delle pubbliche scuole e sulle pagine della Rivista sperimentale di freniatria, della Rivista di psicologia, e del Bullettino delle scienze mediche che ospitarono, quest’ultime, un accesso dibattito con una delle figure scientifiche più competenti in materia, Alfred Binet. Questi di Bellei erano i primi studi in Italia mirati su un argomento che in realtà, da qualche anno, era all’ordine del giorno nel panorama psichiatrico e psicologico nazionale e internazionale. Il medico sceglieva per le sue indagini il “metodo dei dettati” che misurava la stanchezza mentale dei bambini attraverso il numero degli errori compiuti in momenti diversi della giornata scolastica, proposto da Johann Friedrich al III Congresso Internazionale di Psicologia svoltosi a Monaco nel 1896, e molto apprezzato da Ferrari in quanto utilizzava “mezzi d’indagine più espressamente psicologici”, permettendo di “analizzare direttamente gli effetti del lavoro cerebrale prolungato sull’esercizio delle facoltà psichiche”. (10)
pubblicate nel 1901 nel testo La stanchezza mentale nei fanciulli delle pubbliche scuole e sulle pagine della Rivista sperimentale di freniatria, della Rivista di psicologia, e del Bullettino delle scienze mediche che ospitarono, quest’ultime, un accesso dibattito con una delle figure scientifiche più competenti in materia, Alfred Binet. Questi di Bellei erano i primi studi in Italia mirati su un argomento che in realtà, da qualche anno, era all’ordine del giorno nel panorama psichiatrico e psicologico nazionale e internazionale. Il medico sceglieva per le sue indagini il “metodo dei dettati” che misurava la stanchezza mentale dei bambini attraverso il numero degli errori compiuti in momenti diversi della giornata scolastica, proposto da Johann Friedrich al III Congresso Internazionale di Psicologia svoltosi a Monaco nel 1896, e molto apprezzato da Ferrari in quanto utilizzava “mezzi d’indagine più espressamente psicologici”, permettendo di “analizzare direttamente gli effetti del lavoro cerebrale prolungato sull’esercizio delle facoltà psichiche”. (10)
La nascente medicina scolastica trovava così negli studi e nelle ricerche di Albertoni l’importante insegnamento sulla necessità di adeguare la pedagogia e la didattica alle esigenze della fisiologia e insieme l’insegnamento di un metodo che dovesse essere al tempo stesso di indagine sperimentale di laboratorio e di ricerca sul campo. Emergevano temi scottanti del dibattito politico nazionale e comunale sulle riforme scolastiche che toccavano le questioni degli orari, dei programmi, dell’edilizia e quella ancor più spinosa della refezione. Proprio Albertoni fu uno dei protagonisti più attivi, intervenendo in prima persona in Parlamento e in Consiglio Comunale. Già nella celebre prolusione del 1890, mentre toccava, sulla scia dei lavori di Angelo Mosso sulla fatica e di quelli di Moleschott sul rapporto nutrizione e lavoro, temi di fisiologia del lavoro, passando dal lavoro fisico a quello intellettuale, si interessava a quelle problematiche di igiene scolastica che avrebbe poi ripreso al di fuori delle aule dell’Università. Nelle campagne elettorali, in conferenze pubbliche (11) e sulle pagine della Critica sociale e de L’Università italiana (12), da lui diretta dal 1887, lamentava la situazione arretrata dei metodi didattici della scuola italiana che imponevano uno studio mnemonico e pedante poco adatto alla sviluppo naturale dell’intelligenza e del pensiero, una vita sedentaria e un eccessivo affaticamento delle funzioni psichiche e nervose non equilibrato fisiologicamente a un’adeguata alimentazione e a sufficienti intervalli di riposo. Sulla base di chiare cognizioni di fisiologia del sistema nervoso e delle funzioni delle diverse aree del cervello proponeva una diversa ripartizione oraria degli insegnamenti: “i centri più elevati, quelli di associazione, vengono in azione specialmente nello studio della filosofia, delle matematiche, della letteratura, quando occorre pensare e giudicare. Le lingue moderne, soprattutto in quanto si parlano, richiedono l’attività dei lobi occipitali e parietali, area della memoria visiva generale […] alle ore antimerdiane [avrebbe dovuto corrispondere] la filosofia, le matematiche, le lingue morte e le belle lettere, nelle ore pomeridiane la geografia, la geologia, la botanica, il disegno e la calligrafia”.
Come Deputato parlamentare Albertoni chiedeva un maggiore intervento dello Stato, soprattutto economico, nelle questioni scolastiche e lo stanziamento di sussidi che aiutassero gli alunni più poveri, ma il suo intervento fu decisivo soprattutto nella lunga battaglia condotta in Consiglio comunale che portò all’istituzione nel 1903 della refezione scolastica. Nel 1904 ne usufruivano quasi 5000 scolari di famiglie povere. Bologna era stata una delle prime città in Italia a istituirla.
ALESSANDRA CEREA
La fotografia della clinica pediatrica e dell'Istituto di Fisiologia sono conservate presso l'Archivio Storico dell’Università di Bologna.
Si ringrazia la Biblioteca "M.Gatullo" del Dip. di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna per la fotografia del frontespizio del testo di G. Bellei La stanchezza mentale dei bambini delle pubbliche scuole (1901)
L'istituzione della refezione scolastica nel Comune di Bologna
DOCUMENTI
Archivio Storico dell’Università di Bologna. Fascicolo individuale del Prof. Pietro Albertoni
Pietro Albertoni, “La fisiologia e la questione sociale. Discorso inaugurale. Anno scolastico 1890-1891”, in Annuario della Regia Università di Bologna, Bologna, Tip. Successori Monti, 1891, pp. 21-53
Pietro Albertoni, “Scuole ed esami”, L’Università italiana, maggio 1902
Pietro Albertoni, “Significato fisiologico della refezione scolastica”, La critica sociale, 1903, pp. 137-148
Pietro Albertoni, Del sovraccarico intellettuale nelle Scuole medie; quali ne sono le cause e quali i possibili rimedi. Secondo Congresso Nazionale della Federazione fra gl’insegnanti delle Scuole medie. Cremona settembre 1903, Prato, Nutini, 1903
Nicoletta Azzi, Pietro Albertoni. La vita e l’attività, Mantova, Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione nel mantovano, 1984
Nicoletta Azzi (a cura di), Sapere scientifico e questione sociale tra ‘800 e ‘900. Atti del Convegno in occasione della morte del Prof. Pietro Albertoni. Gazoldo degli Ippoliti – Sabbioneta, 12 e 13 ottobre 1984, Mantova, Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione nel mantovano, 1987
Valeria Paola Babini, Medicina e cultura della salute a Bologna (1890-1910), relazione presentata al convegno “Oltre il progresso. La scienza per una società di uomini liberi (1880-1920)”, Accademia delle Scienze, Bologna 25/26 marzo 1992
Valeria Paola Babini, La questione dei frenastenici. Alle origini della psicologia scientifica in Italia (1870-1910), Milano, Angeli, 1996
Giuseppe Badaloni, “L’esame dell’acuità visiva e del senso cromatico nelle scuole, fatto dai maestri elementari”, Bullettino delle scienze mediche, 4, 1904, pp. 381-393
Giuseppe Badaloni, “Sopra qualche dettaglio del banco di scuola in rapporto all’igiene”, Bullettino delle scienze mediche, 6, 1906, pp. 575-584
Giuseppe Badaloni, L’igiene e l’assistenza scolastica in Italia. Relazione dell’ispettore centrale Prof. Giuseppe Badaloni a S. E. il Ministro in occasione della esposizione internazionale di Igiene Sociale in Roma, Roma, Tip. operaia romana operativa, 1912
Giuseppe Bellei, Alfredo Boselli, Relazione sul servizio sanitario scolastico dei medici aggiunti Alfredo Boselli e Giuseppe Bellei / Comune di Bologna, Bologna, Regia Tipografia, 1900.
Giuseppe Bellei, “La stanchezza mentale dei bambini nelle pubbliche scuole”, Rivista sperimentale di freniatria, XXX, 1901, pp. 692-698
Giuseppe Bellei, “Intorno alla stanchezza mentale dei fanciulli delle pubbliche scuole. Risposta ad una critica del Prof. Binet”, Bullettino delle scienze mediche, 6, 1906, pp. 419-432
Giovanni Berti, Sui motivi professionali e sociologici dell’obbligo della pediatria in medicina, con particolare riguardo all’allevamento fisico dell’infante quale elemento formativo della psiche di lui, e quale coefficiente della moralità famigliare, Prolusione al corso ufficiale di Clinica Pediatrica nella Reale Università di Bologna, anno scolastico 1911-1912, Stabilimento Poligrafico Emiliano, Bologna, 1912
Luigi Bombicci, “Dall’asilo infantile all’ateneo attraverso le questioni sociali. Discorso inaugurale. Anno scolastico 1891-1892”, Annuario della Regia Università di Bologna, Bologna, Tip. Successori Monti, 1892
Giuseppe Borgatti, “Prof. Pietro Albertoni”, estratto dalla Rivista di biologia, Vol. XXI, Fasc. II, 1936
Alfredo Boselli, “Sulla correlazione tra scuola e sviluppo fisico dello scolaro”, Bullettino delle scienze mediche, serie VII, vol. I, 1901
Alfredo Boselli, “La refezione scolastica a Bologna. Osservazioni e ricerche”, Bullettino delle scienze mediche, 5, 1905, pp. 583-597
Alfredo Boselli, “Sullo sviluppo fisico ed intellettuale dello scolaro”, Bullettino delle scienze mediche, 7, 1907, pp. 515-532
Vincenzo Cappelletti, “Pietro Albertoni”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, vol. I, 1960
Mirella D’Ascenzo, La scuola elementare nell’età liberale. Il caso bologna (1859-1911), Bologna, Clueb, 1997
Umberto Loreta, Dell’assistenza dei bambini, Conferenza popolare tenuta nella sede della Società operaia di Vignola il 7 gennaio 1893, Stab. Tip. Zamorani e Albertazzi, Bologna, 1893
Umberto Loreta, Come si potrebbe praticamente arrivare ad una riunione di tutte le associazioni e istituzioni a pro dell’infanzia, Congresso internazionale per l’infanzia, Firenze, 1896
Umberto Loreta, Sulla istituzione di sezioni infantili negli Ospedali Comuni, Stab. Tip. Zamorani e Albertazzi, Bologna, 1899
Giuliano Pancaldi, “Gli scienziati, i filosofi, la città”, in Renato Zangheri (a cura di), Bologna, Roma-Bari, Laterza, 1986
Giuliano Pancaldi, “La nascita della clinica sperimentale a Bologna: Augusto Murri e Pietro Albertoni”, in Walter Tega (a cura di) Lo studio e la città: Bologna 1888-1988, Bologna, Nuova Alfa, 1987
Roberta Passione, Le origini della psicologia del lavoro in Italia. Nascita e declino di un’utopia liberale, Milano, Angeli, 2012
Mariano L. Patrizi, “L’opera fisiologica e sociale di Pietro Albertoni”, in Annuario della Regia Università degli Studi di Bologna, 1934, pp. 59-93
Per la Refezione Scolastica nel Comune di Bologna, Bologna, Regia Tipografia, 1903
Angelo Pugliese, “Pietro Albertoni. Il Patriota, lo Scienziato, il Sociologo”, Biochimica e Terapia sperimentale, XX, 1933, pp. 584-589
NOTE
1 Pietro Albertoni, Sul bilancio nutritivo del contadino italiano (1894).
2 Giuseppe Borgatti, “Prof. Pietro Albertoni”, estratto dalla Rivista di biologia, Vol. XXI, Fasc. II, 19
3 Cfr. Giuliano Pancaldi, “Gli scienziati, i filosofi, la città”, in Renato Zangheri (a cura di), Bologna, Roma-Bari, Laterza, 1986.
4 Archivio Storico dell’Università di Bologna. Professori Ordinari (fascicoli individuali), posizione 4/a, busta 2, fasc. c.
5 Cfr. Valeria Paola Babini, La questione dei frenastenici. Alle origini della psicologia scientifica in Italia (1870-1910), Milano, Franco Angeli, 1996.
6 Cfr. Giuseppe Badaloni, “L’esame dell’acuità visiva e del senso cromatico nelle scuole, fatto dai maestri elementari”, Bullettino delle scienze mediche (1904) e “Sopra qualche dettaglio del banco di scuola in rapporto all’igiene”, Bullettino delle scienze mediche (1906).
7 Giuseppe Bellei, Alfredo Boselli, Relazione sul servizio sanitario scolastico dei medici aggiunti Alfredo Boselli e Giuseppe Bellei / Comune di Bologna, Bologna, Regia Tipografia, 1900.
8 Alfredo Boselli, “Sulla correlazione tra scuola e sviluppo fisico dello scolaro”, Bullettino delle scienze mediche (1901) e “Sullo sviluppo fisico ed intellettuale dello scolaro”, Bullettino delle scienze mediche (1907)
9 Giuseppe Bellei, “La stanchezza mentale dei bambini nelle pubbliche scuole”, Rivista sperimentale di freniatria (1901), “Circa i metodi per esaminare la stanchezza dei fanciulli delle pubbliche scuole, Rivista di psicologia applicata alla pedagogia e alla psicopatologia (1906) e“Intorno alla stanchezza mentale dei fanciulli delle pubbliche scuole. Risposta ad una critica del Prof. Binet”, Bullettino delle scienze mediche (1906)
10 Roberta Passione, Le origini della psicologia del lavoro in Italia. Nascita e declino di un’utopia liberale, Milano, Franco Angeli, 2012.
11 Cfr. Questioni scolastiche e fisiologia, conferenzatenuta all’Associazione della Società Magistrale di Mantova nel 1897 e Del sovraccarico intellettuale nelle Scuole Medie: quali ne sono le cause e quali i possibili rimedi, intervento al II Congresso Nazionale della Federazione tra gli insegnanti delle Scuole medie, svoltosi a Cremona nel 1903.
12 Pietro Albertoni, “Scuole ed esami”, L’università italiana, maggio 1902.